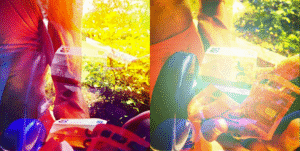Settantamila anime, una notte d’estate, il cielo di Londra che si colora di rosso mentre l’impianto scenografico accende la miccia. Sembra l’inizio di un sogno, e per certi versi lo è. Gli Iron Maiden sono tornati nella loro città, nella loro culla, nel quartiere che li ha visti nascere e sudare: Stratford, East London. Ma non un East London qualunque. Questa volta è lo stadio del West Ham ad accoglierli, il London Stadium, con tutto il carico simbolico che comporta: casa di Steve Harris, il West Ham, squadra della Working Class che da cinquant’anni li segue come una fede. 
 L’impatto è da pelle d’oca.
L’impatto è da pelle d’oca.
Luci, bandiere, birre alzate al cielo. La città è tappezzata di figure con la maglietta di Eddie. I pub di Stratford sono pieni da ore. Tutti sanno che sarà una serata speciale. È la loro Londra, la Londra cupa dei vicoli disegnati da Derek Riggs. E quando partono le prime note di “The Ides of March”, con la band che entra su “Murders in the Rue Morgue”, lo stadio esplode, dimenticando i rammarichi di quella rullata iniziale che, nonostante un goffo tentativo di modifica, non vuol saperne di essere eseguita giusta.
Eppure, sebbene i numeri raccontino una vittoria – 70.000 presenze, il più grande show mai tenuto dagli Iron Maiden in terra inglese da headliner – l’anima della serata lascia un retrogusto strano, amaro, di incompiuto. Come una corsa che parte in quarta e poi inciampa. Una magia imperfetta.
 La location è epica. Non si può negarlo. Harris l’aveva sognato da sempre, quel concerto: suonare a casa, nello stadio della sua squadra del cuore, davanti a una folla oceanica. Qui, al London Stadium, le fondamenta gridano West Ham, gridano gioventù operaia, gridano “Up the Irons” scritto con lo spray sui muri del quartiere.
La location è epica. Non si può negarlo. Harris l’aveva sognato da sempre, quel concerto: suonare a casa, nello stadio della sua squadra del cuore, davanti a una folla oceanica. Qui, al London Stadium, le fondamenta gridano West Ham, gridano gioventù operaia, gridano “Up the Irons” scritto con lo spray sui muri del quartiere.
C’è aria di festa. Gente da tutto il mondo, bandiere ovunque, i fan di sempre mescolati a nuovi adepti che non erano nemmeno nati quando usciva The Number of the Beast. Ma c’è anche qualcosa che stona. Un’aria strana, quella sensazione diffusa che questo, più che un trionfo, sia un giro di boa. Il concerto definitivo prima della discesa. L’ultima volta che li si vede così.
Della scaletta abbiamo già detto, e si sapeva tutto. Sia chiaro: ogni singolo brano è un pilastro. Ma in un tour come questo, dove ci si aspettava qualcosa di unico, bastava pochissimo per farla entrare nella leggenda:
Una “Flash of the Blade” al posto della ritrita “2 Minutes to Midnight”, la butto lì.
Una “Prowler” in onore di Neal Kay, che li lanciò nel mainstream convincendo la EMI a puntare su di loro.
Una dedica, una chicca da fan-club per chi era lì fin dagli inizi.
E invece niente. Nessuna sorpresa clamorosa, è vero che hanno condensato in un’unica tornata brani epici, ma già riproposti in passato.
L’aver ignorato un intero album lascia con qualche domanda. Tre bis scolpiti nel marmo della prevedibilità, identici da anni. Per chi li segue da una vita, e magari ha visto trenta, quaranta concerti, questa assenza di rischio è un tradimento silenzioso. Il pubblico ha cantato, com’è giusto che sia. Ma per i vecchi fan era una messa laica già nota, non una rivelazione.
 Poi c’è la questione più delicata: la batteria. Nicko McBrain, dopo l’ictus del 2023, non può più reggere l’intero set. Un dolore. Un’assenza che pesa. E proprio per questo, ci si aspettava un gesto, una presenza, un momento.
Poi c’è la questione più delicata: la batteria. Nicko McBrain, dopo l’ictus del 2023, non può più reggere l’intero set. Un dolore. Un’assenza che pesa. E proprio per questo, ci si aspettava un gesto, una presenza, un momento.
Ma nulla. Al suo posto c’è un turnista. Bravo, preparato, ci mette l’anima. Ma è Un batterista operaio, di quelli che arrivano, leggono la parte, la suonano, fanno il loro mestiere. E il punto è tutto lì: “il loro mestiere”. Perché i Maiden non sono una band qualsiasi. Le loro canzoni sono costruite su dinamiche teatrali, cavalcate ritmiche che respirano, si aprono, si chiudono. Hanno bisogno di un musicista che interpreti, non che esegua col metronomo. Dawson suona scolastico, rimane spesso indietro, cicca gli attacchi, costringe Harris a seguirlo, minando anche la sua prestazione.
Nicko e Clive suonavano col sangue. E anche se molti fan non lo notano consciamente, lo sentono nell’anima. Le pause non hanno peso. I fill sono privi di carattere. Le impennate su Powerslave, le sezioni narrative su Rime of the Ancient Mariner, i climax di Hallowed Be Thy Name… tutto scorre con un sound molto impoverito. Dice qualche fan:
«È bravo, sì… ma non è Nicko. Suona i pezzi col metronomo.»
— commento da Facebook
«Dawson è preciso, ma manca quel groove che rendeva unica ogni esibizione. Sbaglia spesso, e non emoziona.»
— commento da Reddit
«È stato un grande show. Ma se non c’era Nicko, almeno una dedica, un video, un saluto… ce lo meritavamo.»
— fan italiano su forum Maiden Italy
E bastava poco, di nuovo. Il concerto dei Maiden è una macchina perfetta. Lo sappiamo da sempre, lo show è blindato: le sequenze luci, le animazioni del LED wall, gli ingressi di Eddie, tutto è sincronizzato su un copione immutabile.
Cambiare anche solo un brano comporterebbe una riscrittura dell’intero impianto scenico. E questo, in un tour con venti date, 150 tecnici e un’ora e mezza di pirotecnica… è un delirio.
Quindi non ci aspettavamo una canzone diversa.
Ma un gesto, quello sì. Perché se è vero che la band compie cinquant’anni… Nicko McBrain se n’è fatti 42 di quei cinquanta.
Un’anima, la nostra anima, il ritmo della nostra vita. Un fratello, non un dipendente. E in questa serata a casa, nel quartiere che ha visto la band crescere e imporsi, una sua assenza senza parola è sembrata un buco nero.
Poteva bastare poco. Una standing ovation. Una menzione. Un saluto video.
Un momento. E invece, niente.
Intendiamoci: è stato un bel concerto, grazie alla cornice di pubblico che ha partecipato, effetti spettacolari, suono curato. Bruce ha cantato come ai tempi d’oro, se non meglio. In barba all’età, hanno saltato tutti come grilli. Gli Iron Maiden sono ancora pimpanti. E questo, di per sé, è già meraviglioso. Ma una volta ogni tanto, non si può fare affidamento solo sulla macchina. Ogni tanto, serve cuore.
Serve sporcarsi un poco, cambiare una canzone, dedicare un attimo ai momenti che ci hanno portati fin qui.
Tutto questo non è odio e nemmeno disfattismo. È un guasto d’amore. È la voce di chi ha vissuto questa musica sulla pelle, di chi era presente negli anni bui e in quelli luminosi. È la frustrazione di chi sapeva che non serviva rivoluzionare nulla, ma solo inserire un frammento di verità dentro la perfezione del copione. Nessuno pretendeva un concerto diverso, solo un gesto che lo rendesse speciale.
 Se in 50 anni ti giochi il concerto più grande della tua carriera nel tuo quartiere, non puoi limitarti alla replica.
Se in 50 anni ti giochi il concerto più grande della tua carriera nel tuo quartiere, non puoi limitarti alla replica.
Non puoi non salutare Nicko.
Non puoi non dire una parola per Paul. e Clive.
Non puoi non dedicare un istante a quella storia che hai costruito partendo da un pub di East London con i muri scrostati e una cassetta demo in tasca.
Resterà l’orgoglio di averci creduto. La bellezza di esserci stati. La forza di una band che, anche alle soglie della settantina, ha dato il massimo. Ma per alcuni — e tra questi ci siamo in molti — resterà anche l’amaro in bocca.
Non perché sia mancato qualcosa di tecnico. Ma perché è mancato l’unico ingrediente che non si compra: il cuore. È mancato solo un momento irripetibile, pochi secondi, un istante.
Londra 2025 sarà ricordata per ciò che non è accaduto. Nella serata perfetta per rendere onore a 50 anni di storia, i Maiden hanno giocato sul sicuro.
E non c’è niente di meno maideniano che la sicurezza.